La Città dei due mari
Chiariamo subito questa cosa. Taranto si affaccia sul Mar Ionio, ma vista dall’alto è com se mettesse in comunicazione due specchi d’acqua: uno interno chiamato Mar Piccolo, e uno esterno, detto Mar Grande, delimitato da Punta Rondinella e da Capo San Vito. Per questa ragione, viene anche detta la Città dei due Mari. Sul canale che unisce i due mari è costruito lo straordinario ponte girevole, una meraviglia di cui vi parlerò meglio nell’articolo sul Castello Aragonese, che sembra difendere ancora oggi la città dagli attacchi dei nemici.
Il Mar Piccolo ha una particolarità, dovuta alle sorgenti sottomarini (le Citri) che immettono nel bacino acqua dolce che, mischiandosi all’acqua salata proveniente dal Mar Grande, creano quell’ambiente sottomarino propizio alla coltura delle famosissime cozze nere tarantine (e vi assicuro che, se starete in questa città per almeno un paio di giorni, le troverete anche a colazione e non potrete più farne a meno).
Il Mar Grande ospita dei protagonisti speciali, legati alla mitologia della città: una colonia di delfini che possono essere avvistati, al largo delle isole Cheradi, dallo splendido lungomare, luogo ideale per passeggiare la sera per godere della luce del tramonto e del “rumore di vita” (non saprei definirlo diversamente) di Taranto.
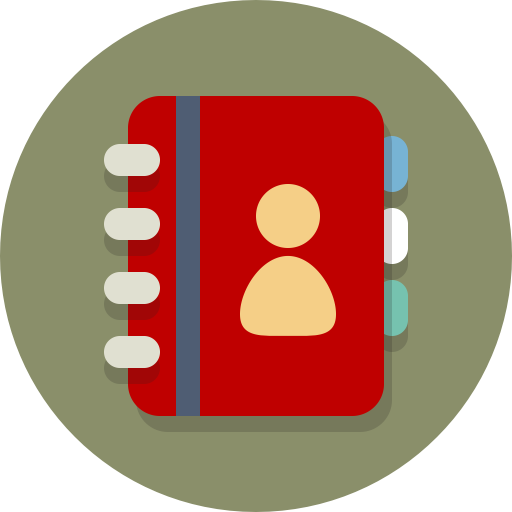
Devo fare una doverosa premessa: Taranto ha davvero tanto da vedere e da scoprire, sia come arte sia come tradizioni e folklore. Io, però, mi sono fermato solo tre giorni e quindi, com’è mia abitudine, vi parlerò di quello che sono riuscito a vedere e scoprire io e non delle cose che potete leggere da soli nelle guide. Sappiate quindi che, oltre a quello che vi racconto in questa pagina, Taranto è molto, molto di più!
Girare per Taranto
Partiamo, quindi, col dire che Taranto è una città di mare, una delle più antiche colonie della Magna Grecia, teatro di scontri, conquiste e storie affascinanti, sede di siti archeologici e, al tempo stesso, perla del sud Italia, con quel calore tipico di una città ricca di carattere, benedetta dal sole, dal mare e dalla voglia di vivere!
Nonostante il porto di Taranto sia fra i più importanti in Italia per traffico di merci, le acque marine intorno alla città sono splendide e particolarmente limpide, a causa della loro bassa salinità: oltre i già citati delfini, che ricorrono anche nello stemma del comune, le acque del golfo ospitano altri cetacei e colonie di cavallucci marini e fenicotteri rosa (ogni anno è possibile ammirare la “danza” dei fenicotteri rosa nella riserva naturale tra Torre Colimena e Specchiarica, sulla Litoranea tarantina).
Il mare è per tutti i gusti: sulla costa occidentale ci sono spiagge molto ampie, mentre su quella orientale la fanno da padrone le dune e la macchia mediterranea, tra decine di piccole baie con gli scogli.
Fu l’ultima città della Magna Grecia a cadere a causa dell’espansione di Roma, dando filo da torcere agli eserciti nemici (le guerre pirriche durarono 5 anni). Pur conquistata esercitò sempre una forte influenza su tutto il resto del territorio, al punto da essere celebrata da tanti autori, a partire da Orazio, e da risultare come radice nel nome di specie di animali (la tarantola vi dice qualcosa?) e balli popolari (eh, si: la tarantella deriva da qua).
Esiste una città “vecchia” o “borgo antico”, situato su un’isola all’incontro dei due mari, dove di trova il centro della storia e della tradizione: dal Tempio di Poseidone (il più antico della Magna Grecia) al Castello Aragonese (voluto in questa forma da Ferdinando I di Napoli nel 1486), dalla Cattedrale di San Cataldo (patrono della città) ai musei ipogei nascosti sotto le case. E poi, ancora, lo stretto dedalo di viuzze dove scoprire gli artigiani, le taverne a gestione familiare, i murales sulle vecchie porte che reinterpretano i miti antichi, la passeggiata lungo la marina alle prime luci dell’alba, per vedere le barche dei pescatori che scaricano il “bottino”, oppure dalla parte opposta, lungo “la ringhiera“, per fermarsi in uno dei tanti locali a prendere un aperitivo mentre il sole tramonta. Ho letto in altre guide di stare attenti a girare in queste zone, ma vi devo dire che io viaggio da solo e non mi sono mai sentito in pericolo… anzi! La familiarità delle persone che ho incontrato (esclusi i parcheggiatori abusivi, che sono l’obolo di ogni turista che vuole stare sereno e non passare la giornata in auto) mi ha fatto sentire accolto come in un grande salotto a qualsiasi ora del giorno o della notte. A essere onesti, molti edifici sono un po’ fatiscenti e alcuni tratti del borgo richiederebbero un restauro, quantomeno per dare a quest’area la dignità che l’importanza storica le attribuisce di diritto.
La città vecchia è collegate da due ponti: il ponte di pietra (del 1883), che porta alla zona industriale, e il ponte girevole (del 1887), che conduce alla città moderna, dove si svolge la vita quotidiana della città, ci sono le vie dello shopping, il lungomare, la Concattedrale di Taranto dedicata alla Gran Madre di Dio, e dove ha sede il prestigioso MArTa ovvero il Museo Archeologico Nazionale di Taranto.
Il Monumento al Marinaio
Sul Corso Due Mari, proprio di fronte al Castello Aragonese, vicino al ponte girevole, c’è un statua singolare per cui vale la pena spendere due parole. Sembrano i personaggi di qualche videogioco che lanciano dischi non ben identificati, e invece il simbolismo che c’è dietro mi ha colpito.
Partiamo col dire che Taranto ha sempre avuto, nella storia, un legame con la Marina Militare Italiana, solo che quest’ultima nasce con la Repubblica. La sua antenata era la “Regia Marina” (accento sulla e, non sulla i, altrimenti diventa un film). Il presidente del Consiglio Cavour, aveva le idee chiare sul voler dare al Regno un carattere marittimo:
Voglio delle navi tali da servire in tutto il Mediterraneo, capaci di portare le più potenti artiglierie, di possedere la massima velocità, di contenere una grande quantità di combustibile […] consacrerò tutte le mie forze […] affinché l’organizzazione della nostra Marina Militare risponda alle esigenze del Paese
.

Stemma della Regia Marina
Facciamo un salto nel tempo fino al ventennio fascista, durante la Seconda Guerra Mondiale, e più precisamente nel 1940. L’Italia ha da schierato nel porto di Taranto la Vittorio Veneto e la Littorio, tra le più potenti navi da battaglia dell’epoca. La posizione di Taranto era centrale rispetto al Mediterraneo, e questo preoccupava gli Alleati, in particolare la Gran Bretagna. Quando la Royal Navy apprese che nel porto di Taranto si erano riunite anche le navi da battaglia Andrea Doria, Cavour, Giulio Cesare, Duilio, gli incrociatori Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara, Duca degli Abruzzi e la Garibaldi e vari cacciatorpediniere, l’ammiraglio Andrew Cunningham avviò l’Operazione Judgement ordinando l’attacco alla flotta italiana, che subì serie perdite, come l’affondamento della Cavour e il danneggiamento della Littorio e della Duilio, rendendole non disponibili alle battaglie successive. La sconfitta morale per il regime fascista fu tale, che la notte tra l’11 e il 12 ottobre 1940 viene ricordata come “La Notte di Taranto“.
Durante quella notte, Angelo Iachino era Ammiraglio di Squadra e partecipò alla battaglia.
Circa 30 anni dopo, nel 1974, l’Ammiraglio d’Armata in congedo Iachino volle donare alla città di Taranto il monumento in bronzo che ancora oggi accoglie o accomiata le navi che attraversano il canale tra i Due Mari.
Il Monumento al Marinaio, realizzata dallo scultore Vittorio Di Cobertaldo, è in continuità con la ringhiera su cui sono incise la stella a cinque punte e lo stemma della Marina dei Savoia, a simboleggiare il legame che c’è tra la Marina Militare e la città di Taranto.

Le due figure rappresentano due marinai che salutano i loro compagni in mare, che arrivano dopo una navigazione o che lasciano il porto. I dischi nelle loro mani sono le “pizze”, i berretti tipici della divisa da marinaio, comune alle marine di tutto il mondo. Sono privi di visiera e di qualsiasi altro appiglio, per cui l’unico modo per afferrarli e agitarli in n saluto è quello stilizzato dalle due statue.
Osservando i 2 marinai, questi sembrano comporre insieme una stella a cinque punte. Osservando anche la stella sulla ringhiera, mi sono ricordato che per i militari che le indossano, le stelle sono “il simbolo del solenne giuramento di servire e difendere con disciplina e onore la Patria, fino all’estremo sacrificio“. Non so se sia quello che voleva dire l’autore, ma a me è piaciuto pensarlo così.

La scheda della Città
- Superficie: 294,86 km²
- Abitanti: 188.098 (31-12-2022)
- Densità: 752,81 ab./km²
- Altitudine: 15 m s.l.m.
- Nome abitanti: tarantini
- Patroni: San Cataldo
- Festa patronale: 10 maggio
- Prefisso: 099
- Targa: TA (Taranto)
- Provincia: TA (Taranto)
- Soprannome: La città dei due mari

Lo stemma del Comune di Taranto riporta il simbolo della città, costituito dal giovane Taras, figlio di Nettuno, a cavallo di un delfino. Per saperne di più, leggi l’articolo sulla storia delle origino della città nella sezione Miti, Leggende e Curiosità (link qui sotto).
Per rendere unica la mia visita, ammetto di aver avuto una guida d’eccezione: avevo conosciuto Francesco un paio di anni prima durante un evento scout in Olanda e non ci eravamo più visti, ma è bastata una telefonata e, a testimonianza della grande ospitalità dei tarantini, si è fatto in quattro per rendere il mio breve tempo in città, un tempo di qualità!
Grazie Francesco!

Come arrivare a Taranto
L’aeroporto più vicino è il “Marcello Arlotta” che dista 16 Km dalla città, ma effettua solo voli charter e low cost.
Le ferrovie collegano la città con Bari, Brindisi e la Calabria.
Se viaggiate in auto, Taranto è raggiungibile:
- percorrendo l’ Autostrada A14 se arrivate da nord,
- con la S.S. 106 Ionica se venite dalla Calabria,
- con la S.S. 100 se venite da Bari,
- con la S.S. 7 Appia se venite da Brindisi.
Muoversi a Taranto
Taranto è una grande città ma si visita bene anche senza auto sfruttando il trasporto pubblico.
Se avete poco tempo a disposizione e vi volete concentrare sulla Città Vecchia, allora scordatevi pure i mezzi di trasporto: la maggior parte dell’area è isola pedonale e si gira a piedi. Attraversato il ponte girevole, a pochi passi, troverete il lungomare, il MArTa e corso Umberto I, quindi risparmiatevi lo stress di incanalarvi nel traffico e cercare un parcheggio.
Per percorsi più lunghi, potete utilizzare il trasporto pubblico (che comunque non vi salva dal traffico). L’azienda dei trasporti è l’AMAT (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto), che conta una ventina di linee urbane e i biglietti si possono acquistare presso le edicole, tabacchi e presso i punti vendita e stazione.
Oltre alla corsa singola da 90 minuti, sono disponibili titoli di viaggio validi per 3 o 7 giorni.
Nei mesi estivi si aggiunge l’idrovia che collega piazzale Democrate a Capo San Vito, passando dal Mar Piccolo e dal Canale navigabile tra i Due Mari.

Quello che ho amato fare a Taranto
Diario di Viaggio
Mettendo sempre le mani avanti per il fatto che sono stato a Taranto poco tempo rispetto a quanto avrebbe meritato, ecco una lista delle cose che vi consiglio di non perdere:
- Esplorare i vicoli del Borgo Vecchio alla ricerca di chiese, murales e scorci caratteristici da fotografare.
- Guardare il tramonto sorseggiando un aperitivo fresco da uno dei locali lungo la ringhiera.
- Svegliarsi prima dell’alba per fare colazione tra via Cariati e via Garibaldi mentre i moli e le passerelle in mezzo al mare prendono vita grazie ai pescatori che scaricano il “bottino”.
- Visitare il MArTa e restare affascinati dai reperti paleolitici e dagli “Ori di Taranto”.
- Sostare un po’ a naso in su nel silenzio della Cattedrale di Taranto.
- Immaginare le sanguinose battaglie dei tempi antichi davanti alla maestà dei resti del Tempio di Poseidone.
- Cenare a base di pesce fresco, sentendo tutto il sapore del mare, con le immancabili cozze nere tarantine.
- Prenotare l’ultima visita della giornata al Castello Aragonese, percorrere i suoi cunicoli e sbucare ai piedi del ponte girevole illuminato nella notte.
- Posizionarsi, al tramonto, sul Corso Due Mari, nei pressi del Monumento al Marinaio, per assistere alla cerimonia di ammaina bandiera che si tiene sulle mura del Castello sulla riva opposta.
- Passeggiare sul Lungomare e buttare ogni tanto un occhio al largo nella speranza di vedere un delfino (so che ci sono dei tour apposta per ammirare la fauna marina del Mar Grande, ma con poco tempo a disposizione non sono riuscito a trovare posto, purtroppo)… e non vedendo i delfini, accontentarsi delle statue delle sirene che spuntano dalle acque.
- Godersi la folla della sera e prendersi una bevanda fresca su Via d’Aquino, con l’altissima probabilità di attaccare una chiacchiera con altri turisti.
- Studiare l’architettura della Concattedrale di Taranto cercando di capire se ci piace o no…
- Pranzare con un piatto di spaghetti alle cozze nere tarantine accompagnati da una birra Raffo, detta anche “birra dei due mari” o “birra dei tarantini”, quella che ha sull’etichetta l’immagine di Taras a cavallo del delfino.
La leggenda delle sirene
Si narra che, ai tempi in cui Taranto era la Capitale della Magna Grecia, alcune sirene decisero di costruire un castello fatato tra le acque della citta. Qui viveva una giovane coppia: una bellissima ragazza e un pescatore che, per il suo mestiere, doveva restare spesso lontano da casa.
La solitudine fa fare cattive scelte e così la ragazza, a causa della lunga assenza del marito, finì per cedere alla pressante corte di un ricco signore. Ma le cattive scelte generano rimorsi e così ella non riuscì a non confessare tutto a suo marito che, in preda all’ira e alla gelosia, la portò con sé in barca e la spinse in acqua perché annegasse. La giovane fu salvata dalle sirene che, ammirandone la bellezza, ne fecero la loro regina dandole il nome di Skuma, che vuol dire “schiuma” poiché proprio la schiuma delle onde del mare l’aveva portata fino a loro.
Il pescatore si recò più e più volte nel punto in cui aveva visto annegare la moglie passandovi giornate a piangere lacrime di rimorso per il gesto che aveva fatto. Le sirene, vedendolo, lo incantarono fino a spingerlo a buttarsi in acqua, lo rapirono e lo condussero al cospetto della loro regina. Skuma lo riconobbe e lo perdonò, convincendo le sirene a lasciarlo in vita.
Riportato a riva, il ragazzo si mise in testa di rimediare all’errore e di riconquistare la moglie. Si rivolse a una fata, che gli rivelò che per liberare la ragazza avrebbe dovuto rubare un fiore bianco dal castello delle sirene.
Qui la tradizione si divide…
Primo finale
Grazie a uno stratagemma per distrarre le sirene (alcuni gioielli in una barca) il pescatore riuscì a recuperare Skuma e a riportarla a riva rubando il fiore che donò alla fata. La fata, per ricompensa, generò un’onda tale da spazzare via le sirene dal golfo di Taranto.
Skuma e il pescatore vissero per sempre felici e contenti!
Secondo finale
Dopo che la fata ricevette la rosa, generò l’onda per spazzare via le sirene, ma rimase coinvolto anche il pescatore, che non riuscì a sottrarsi dalle acque e morì in mare.
Skuma, allora, si ritirò a vita monastica in una delle torri del Castello Aragonese fino alla morte e si narra che, ancora oggi, nelle notti di plenilunio, si possa vedere il fantasma di una monaca aleggiare sulle acque in cerca del suo amato, infelice per l’eternità.
Indipendentemente da quale finale scegliate, mentre passeggerete per il lungomare di Taranto gettate sempre un occhio tra gli scogli e forse scorgerete la statua di una sirena. Si tratta di opere realizzate da Francesco Trani in cemento marino, ossia un materiale in grado di resistere alla salsedine e all’azione corrosiva del mare… in pratica eterne come l’amore dei due ragazzi della favola.
La processione di Pasqua
Dalla Domenica delle Palme, per tutta la Settimana Santa, Taranto si veste di tradizione e folklore, grazie alle due Confraternite principali della città:
- la Confraternita dell’Addolorata, che fa capo alla chiesa di San Domenico Maggiore (nel Borgo Antico),
- la Confraternita del Carmine, che fa capo alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo (nel Borgo Nuovo).
Le due Confraternite si contendono le statue e le poste per le processioni dell’Addolorata e dei Misteri, rispettivamente. Per farlo, viene bandita una vera e propria asta con banditore per aggiudicare la statua al confratello che porta l’offerta più alta. Chiaramente, i proventi vanno in beneficenza.
Le statue del Cristo Morto e della Madonna Addolorata risalgono al 1703, quando don Diego Calò, marito della nobile tarantina Ippolita Imberverato, le fece realizzare a Napoli.
Figure tipiche di questi riti sono i Perdoni (coloro che vanno in pellegrinaggio per chiedere perdono), Confratelli della Chiesa del Carmine che nella Settimana Santa vanno in processione per le vie di Taranto con un moto lento e un dondolio che, in dialetto tarantino, è detto “nazzecata”.
Sono scalzi, vestiti di bianco, con cappuccio bianco (con solo due fori per gli occhi), guanti bianchi, bastone del pellegrino e corona di sterpi sul capo, oltre a tutta una serie di simboli legato alla devozione per il Carmelo e alla passione di Gesù.
Uno di questi è detto “troccolante“, perché ha in mano la “troccola“, overo uno strumento musicale a percussione diretta, composto da una tavola di legno su cui sono installate delle “maniglie” in metallo: agitandola, le maniglie metalliche percuotono il legno producendo un suono caratteristico. In molte parto dell’Italia Meridionale la troccola viene utilizzata in Settimana Santa (in cui non si possono suonare le campane) per creare l’atmosfera della terra scossa dalla morte di Gesù, in quel periodo di buio che precede la luce della Resurrezione.
Al termine della via Crucis iniziata la sera prima, la mattina del sabato il troccolante si ferma davanti alla porta in legno della chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo e, agitando la troccola, batte 3 colpi con il suo bastone del pellegrino per farsi aprire.
A quel punto possono rientrare le 8 statue della processione dei Misteri (quelle che erano stato battute all’asta): Gesù nell’orto degli ulivi, Ecce Homo, La Colonna, La Cascata, il Crocifisso, la Sacra Sindone, Gesù Morto e l’Addolorata.
Il rito dell’apertura della porta si svolge sotto lo sguardo silenzioso della folla che alla fine esplode in un applauso liberatorio. Sulla porta, a osservare bene, si possono vedere tutto l’anno i segni dei colpi del troccolante.













